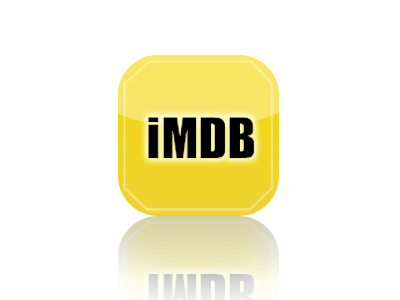Ma il nome di Roma era giunto ancora più lontano, sicché Augusto è legittimato a ricordare con orgoglio che “furono inviate spesso a me ambascerie di re dall'India, mai viste prima di allora da nessun comandante romano.
di Ciro Oliviero Gravier
Gruppo Archeologico Veliterno - Quarta e ultima parte
Chiesero la nostra amicizia per mezzo di ambasciatori i Basrani, gli Sciti e i re dei Sarmati che abitano al di qua e al di là del fiume Tànais”. Una prima ambasceria indiana era approdata a Tarragona (26-25 a. C.), poi una seconda raggiunse Augusto a Samo (21-20 a. C.): avevano compiuto un viaggio di quattro anni e, di tanti che erano partiti, erano rimasti in tre, ma portavano con loro i ricchissimi strabilianti doni a lui destinati. Innanzitutto, gli ambasciatori consegnarono ad Augusto una lettera scritta in greco, in cui il loro re Poro si vantava di essere re di seicento re e chiedeva ciononostante l’amicizia di Augusto promettendogli libero passaggio nelle sue terre. Furono poi introdotti otto schiavi nudi dalla cintola in su, che presentarono all’imperatore di Roma perle, pietre preziose, elefanti, tigri, un serpente lunghissimo, una testuggine lunga tre braccia, una pernice più grande di un avvoltoio ed anche un uomo senza braccia che scoccava frecce dall’arco coi piedi e suonava magnificamente la tromba, aiutandosi sempre con i piedi. Quanto ai popoli “al di qua e al di là del Tànais” (il Don, il fiume convenzionalmente indicato come confine tra l’Europa e l’Asia), essi erano noti ai Greci da lunghissimo tempo (per primo ne aveva parlato Erodoto) e ai Romani di certo attraverso i Greci, ma contatti fra essi e i Romani non c’erano mai stati prima di allora. Gli Sciti, divisi in molte tribù, occupavano il vasto territorio tra il Dniepr ad ovest e il Don ad est, con a sud il fronte marittimo della Meotide (il Mare d’Azov) e il Ponto Eusino, mentre a nord si perdevano nelle inesplorate terre dove si diceva che abitassero gli Agatirsi. Oltre il Don, intorno al Volga e più oltre, si estendevano i territori dei Sàrmati. Né poteva certo omettere il grande successo della restituzione delle aquile romane catturate anni prima e detenute dai Parti: “Costrinsi i Parti a restituirmi spoglie e insegne di tre eserciti romani e a chiedere supplici l'amicizia del popolo romano. Quelle insegne, poi, riposi nel penetrale che è nel tempio di Marte Ultore”. Augusto aveva dieci anni quando si verificò il disastro di Carre (53 a.C.), e certo la notizia terribile dovette fare sull’animo del giovinetto un’impressione non meno forte e dolorosa di quella del disastro di Teutoburgo nell’animo dell’uomo maturo. Crasso, che aspirava a ritagliarsi il merito militare la cui mancanza gli creava un insopportabile sentimento di inferiorità rispetto agli altri due triumviri Cesare e Pompeo, si avventurò nel Regno dei Parti (che si estendeva dall’attuale Turchia orientale fino all’attuale Afganistan occidentale) nell’intento di conquistarlo, quasi nuovo Alessandro. Per una serie ininterrotta di errori tattici e strategici, andò invece incontro ad una terribile sconfitta e alla sua stessa morte. Per vendicare questa sconfitta e l’affronto delle insegne trattenute, l’allora giovane Caio Ottavio stava per dare l’ordine di marcia alle legioni quando giunse ad Apollonia la notizia che Cesare era stato assassinato tre giorni prima. La spedizione fu pertanto rinviata, per causa di forza maggiore. Poi avvenne che Quinto Labieno, il pur fidato luogotenente di Cesare nelle Gallie, parteggiò per i cesaricidi e, dopo Filippi, chiese aiuto ai Parti contro i Romani, che nel 40 a.C. furono sconfitti ad Apamea (nella Siria attuale) e solo la valentia di Publio Ventidio Basso riuscì a capovolgere la situazione a favore dei Romani. Per la terza volta ci provò anche Marco Antonio, ma dovette ritirarsi senza aver raggiunto il successo che pure era sicuro di raccogliere (37 a.C.). Sui Parti regnava il re Fraate IV che aveva ucciso suo padre per salire al trono. Gli si oppose Tiridate II che lo destituì, ma Fraate riprese il potere con l’aiuto degli Sciti. Tiridate ci riprovò senza successo e allora raggiunse Augusto in Spagna consegnandogli un figlio di Fraate che aveva rapito. Augusto rimandò il ragazzo dal padre senza chiedere nessun riscatto, ma facendogli capire che conveniva cessare ogni ostilità con Roma, e Fraate, a questo punto (20 a.C.), consegnò le insegne che 33 anni prima erano state catturate a Carre e 209 soldati romani superstiti. È dunque vero che i Parti restituirono “il maltolto” e fu finalmente recuperato l’onore perduto, ma Augusto si guarda bene dal dire che il successo non fu militare, ma diplomatico, mentre sostiene di avere “costretto” i Parti a “restituire le spoglie e le insegne di tre eserciti”, che invece erano quelle di uno solo (quello dello sfortunato Crasso). Se ne fece però fare un “ritratto” che possiamo ancora oggi ammirare sulla sua corazza nella statua celeberrima di Prima Porta: un dignitario parto consegna un’insegna militare ad un ufficiale romano. E poi la stoccata finale: “Nel mio sesto e settimo consolato trasferii dalla mia persona al Senato e al Popolo Romano il governo della Repubblica. Per questo mio atto, in segno di riconoscenza, mi fu dato il titolo di Augusto per delibera del Senato. Dopo di che, sovrastai tutti per autorità, ma non ebbi potere più ampio di quelli che mi furono colleghi in ogni magistratura”. Nella memorabile seduta del 13 gennaio 27 a.C. Caio Giulio Cesare Ottaviano effettivamente dichiarò di riconsegnare ogni sua carica al Senato e al Popolo Romano, e in cambio ottenne non solo la riconferma, ma anche il titolo di Augusto. Il Senato, da quando lui era tornato vittorioso dall’Egitto, pur mostrandosi formalmente ossequiente, in realtà gli faceva una cupa fronda sotterranea. I senatori non avevano digerito, ad esempio, la nuova organizzazione delle province che toglieva loro una serie di lauti privilegi, e avevano apertamente criticato l’operato del prefetto d’Egitto Cornelio Gallo il quale si era permesso di stipulare trattati internazionali, contro l’antico principio secondo il quale la politica estera era di stretta competenza del Senato. Quegli che tre giorni dopo sarà chiamato Augusto, convocò il Senato e tenne ai senatori sbigottiti un discorso contemporaneamente corretto e provocatorio. Disse, tra l’altro: “Depongo tutto il potere, vi restituisco tutto: le armi, le leggi, le province … Dal momento che la sorte vi ha restituito con l’opera mia la pace vera e la concordia senza lotte, ora accettate la libertà e l’antica forma della Repubblica. Ricevete le armi, le genti soggette a voi e gestite lo stato a modo vostro”. In altre parole: fatemi vedere che cosa siete capaci di fare, oltre che chiacchiere e critiche vacue! I senatori, dinanzi al baratro del vuoto di potere che si apriva improvvisamente sotto i loro piedi e messi dinanzi all’alternativa di assumersi le responsabilità del governo o lasciarle a chi solo, in quel momento, era in grado di esercitarle, respinsero, deferenti e tremebondi, l’offerta e gli decretarono anche, su proposta (concordata) di Lucio Munazio Planco, uno statuto sacrale col titolo di Augustus. La conclusione, corretta, per cui sovrastò tutti per autorità (auctoritate omnibus praestiti), ma non ebbe potere maggiore (potestatis autem nihilo amplius …) di quello dei suoi colleghi nelle diverse magistrature, va letta alla luce della distinzione semantica tra “auctoritas” (che è una preminenza assoluta e sacrale al di sopra del diritto) e “potestas” (che è la specifica competenza di ciascuna magistratura, codificata nel diritto), e alla palmare evidenza politica che i senatori avevano rinunciato all’ “antica forma della Repubblica”. Non restava più che chiamarlo Padre della Patria. E anche questo fu fatto! “Il Senato, l’ordine equestre e l’intero Popolo Romano mi chiamò Padre della Patria” (“Senatus et equester order populusqu Romanus universus appellavit me patrem patriae”. Celebrati che furono i solenni funerali e deposta l’urna nel grandioso Mausoleo, le vergini Vestali consegnarono ai familiari di Augusto il rotolo contenente il testo delle res gestae che furono incise su tavole di bronzo collocate a Roma proprio all’ingresso del Mausoleo. Altre copie furono fatte scolpire su bronzo o su marmo e collocare ai quattro angoli dell’Impero. Di esse, quella più lunga giunta fino a noi era sul Tempio di Augusto e Roma ad Ancyra (Ankara). Oggi chi volesse leggerle per intero, in lingua latina, non ha che da raggiungere l’Ara Pacis a Roma e, senza neanche entrarci, mettersi in via di Ripetta con le spalle al Mausoleo.